I frutti di Camus a maturazione
“la peste aveva ricoperto ogni cosa: non vi erano più destini individuali, ma una storia collettiva, la peste, e dei sentimenti condivisi da tutti.”
Terzo momento, integralmente incardinato su La Peste - dell’indagine sulla scrittura e sulla visione filosofica di Albert Camus. V. anche I frutti di Camus e Le madri di Camus.
Joseph Grand, volendo imparare a trovare le parole, scopre che la donna che lo ha lasciato, e alla quale sempre pensa, avrebbe potuto essere trattenuta se solo, a un dato momento, egli fosse riuscito a trovare le parole. Ma non ha potuto.
Adesso il Romanzo, come si conviene, tutto ricomprende: l’amore, il cinismo, la pietà, l’astratto (non più l’assurdo della peste), la paura, il diritto alla felicità di ogni uomo.
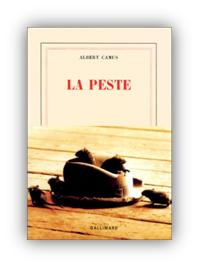 La scrittura di Camus lievita come un’estate feroce: flutti ininterrotti di Romanzo inondano le sue pagine. Il microcosmo di Orano, vetrino da esperimento per le passioni di un’umanità al limite tra disgregazione e solidarietà – così, molto felicemente, recita il testo della quarta di copertina – è puntualmente indagato in ogni suo recesso. La peste è un romanzo talmente ambizioso che una volta riuscito non può non essere classificato patrimonio dell’umanità. Il suo vertiginoso coefficiente di difficoltà, insito nel non irrilevante problema di restituire in modo credibile al lettore un universo colpito dalla peste, diventa quindi il tratto più prestigioso dell’opera. Questo avviene perché, ad onta della natura tutta finzionale dell’espediente narrativo della pestilenza, mai, davvero mai, quella che tecnicamente si chiama sospensione dell’incredulità viene a subire contraccolpi. In maniera molto volgare, o in due parole, siamo dalle parti della lettura avvincente.
La scrittura di Camus lievita come un’estate feroce: flutti ininterrotti di Romanzo inondano le sue pagine. Il microcosmo di Orano, vetrino da esperimento per le passioni di un’umanità al limite tra disgregazione e solidarietà – così, molto felicemente, recita il testo della quarta di copertina – è puntualmente indagato in ogni suo recesso. La peste è un romanzo talmente ambizioso che una volta riuscito non può non essere classificato patrimonio dell’umanità. Il suo vertiginoso coefficiente di difficoltà, insito nel non irrilevante problema di restituire in modo credibile al lettore un universo colpito dalla peste, diventa quindi il tratto più prestigioso dell’opera. Questo avviene perché, ad onta della natura tutta finzionale dell’espediente narrativo della pestilenza, mai, davvero mai, quella che tecnicamente si chiama sospensione dell’incredulità viene a subire contraccolpi. In maniera molto volgare, o in due parole, siamo dalle parti della lettura avvincente.
La congerie umana gode qui di una rappresentazione completa e approfondita. Abbiamo visto Joseph Grand, adesso mette conto parlare della straordinaria figura del padre gesuita Paneloux. Sembrerebbe sulle prime, un teologo colto e integerrimo, una specie di prefetto della congregazione per la dottrina della fede, pronto a giustificare la pestilenza come punizione biblica venuta a colpire i molti che hanno perso di vista Dio o che si sono troppo adagiati sulla sua misericordia impedendosi così di soddisfare il suo “divorante affetto”. A mio parere, il personaggio viene omaggiato da Camus di un’eccellente retorica e di una grande capacità evocativa e visionaria (la sua prima omelia sul castigo divino resta un ‘evento’), il che consente all’autore di meglio precisare il suo dissenso dall’interpretazione religiosa senza però ridurre a macchietta l’uomo di chiesa né banalizzare la stessa chiesa. Camus può prendere rispettosamente ma fermamente le distanze da un approccio filosofico che non condivide: la giustizia divina che s’abbatte sul mondo per ripulirlo dalla colpa. Ove mai Paneloux riveli un limite, questo non andrebbe individuato nel dogmatismo di un retrivo ministro di dio ma al più nel suo procedere in un sistema sì dotto da scontare un certo distacco dal mondo degli uomini, una freddezza, al cospetto del dolore, che non è di alcun beneficio alla religione medesima. “Paneloux è un uomo di studio, non ha veduto morire abbastanza.”
Ma poi la peste cos’è? Un portiere comincia col delinearla in conformità con quelli che sono gli intenti allegorici dell’autore: “Se fosse stato un terremoto! Una buona scossa e non se ne parla più … Si contano i morti, i vivi, e il gioco è fatto. Ma questa porcheria di peste! Anche coloro che non l’hanno la portano nel cuore”.
Le scelte morali
Tarrou ha una sua morale, qual è? La comprensione.
Rieux, a sua volta, quella di curare la miseria.
E ancora, la morale del Narratore (il quale interviene in prima persona a pag. 101): “dando troppa importanza alle buone azioni si finisce col rendere un omaggio indiretto e potente al male: allora, infatti, si lascia supporre che le buone azioni non hanno pregio che in quanto sono rare e che la malvagità e l’indifferenza determinano assai più frequentemente le azioni degli uomini”. Il Narratore si fa “storico dei cuori straziati ed esigenti che la peste diede allora a tutti i nostri concittadini.”
Poi c’è Cottard, il prototipo dell’uomo che si trova meglio da quando nella sua città s’è installata la peste.
Il giornalista Rambert non fa che escogitare fughe da Orano perché non crede nell’eroismo, anzi peggio, lo crede omicida. E ciò che egli trova davvero importante nella vita è “che si viva e che si muoia di quello che si ama”.
 Camus ci prova, tenta di sfidare l’assenza di senso dell’esistere, estende il contagio fino a quando questo non ha eliminato tutti i giudizi di valore. “Si accettava tutto in blocco”, scrive sfidando la sue stessa creazione letteraria, quella che gli sta alle spalle. Con questo suo estremo tentativo, prova a sterilizzare l’amore fino a creare un mondo insensato, basato sulla “pazienza senza futuro” e su “un’attesa incagliata”, nel quale gli uomini restano uccisi come mosche. Ma resta, per così dire, vittima della immensa sua costruzione. Adesso non può fare a meno di osservare “l’appetito di calore umano che spinge tuttavia gli uomini gli uni verso gli altri”, e li spinge fino anche alla spasmodica ricerca di quei “torridi piaceri che li difendevano dal gelo della peste”.
Camus ci prova, tenta di sfidare l’assenza di senso dell’esistere, estende il contagio fino a quando questo non ha eliminato tutti i giudizi di valore. “Si accettava tutto in blocco”, scrive sfidando la sue stessa creazione letteraria, quella che gli sta alle spalle. Con questo suo estremo tentativo, prova a sterilizzare l’amore fino a creare un mondo insensato, basato sulla “pazienza senza futuro” e su “un’attesa incagliata”, nel quale gli uomini restano uccisi come mosche. Ma resta, per così dire, vittima della immensa sua costruzione. Adesso non può fare a meno di osservare “l’appetito di calore umano che spinge tuttavia gli uomini gli uni verso gli altri”, e li spinge fino anche alla spasmodica ricerca di quei “torridi piaceri che li difendevano dal gelo della peste”.
Intanto Paneloux, dopo aver assistito alla straziante agonia di un bimbo ucciso dalla peste, e non potendo trovare giustificazione, neanche nella vita eterna, per lo scandalo delle sofferenze inflitte ai bambini, giunge al fondo, ai piedi della muraglia mortifera della peste, ovvero alla sostanza della scelta religiosa: “tutto credere per non essere ridotto a tutto negare”. Comprende che l’esperienza del dolore è anche e soprattutto il lascito del suo maestro, il Maestro dei cristiani, il quale la sofferenza ha conosciuto “nelle membra e nell’anima”. E il non esser ridotti a tutto negare suona, a sua volta, in opposizione al tipo umano conosciuto ne Lo straniero. Dunque cosa fare nel bel mezzo della tempesta? “Bisogna essere colui che resta”. Questo passaggio illustra altresì il mutamento di Camus. Essere colui che resta, camminare un po’ alla cieca nelle tenebre per tentare di fare del bene (sono queste le parole della seconda predica di Paneloux), sembrano le scelte che identificano quel “criterio minimo” che guida la morale di Camus. “Quando all’innocenza fanno crepare gli occhi, un cristiano deve perdere la fede o accettare che crepino gli occhi anche a lui.”
Tarrou dice: “Bisogna rifiutarsi di essere col flagello”. Aggiungendo, però, questa volta (pag. 195), elementi, riguardo alla peste, che procurano un primo sobbalzo al lettore. Egli parla di una malattia che ogni uomo porta dentro di sé, di un contagio da cui nessuno al mondo può ritenersi immune. Rieux, pure, saprà che la peste è una minaccia perenne, che il suo bacillo non muore mai e può annidarsi ovunque, addirittura nei posti a noi più familiari, restarvi addormentato per anni, fino a quando non deciderà di risvegliarsi. Allora nel lettore cominciano ad emergere più chiaramente le intenzioni dell’autore. Tarrou spiega che è faticoso essere appestati ma ancora più faticoso è non volerlo essere e che se si sceglie questa seconda via non bisogna allora concedersi distrazioni, s’imbocca una specie di ascetismo, si tenta cioè la santità.
Rieux, il quale nel frattempo ha riconosciuto in Tarrou un amico prezioso, gli replica: “Ma lei sa, io mi sento più solidale coi vinti che coi santi. Non ho inclinazione, credo, per l’eroismo e per la santità. Essere un uomo, questo m’interessa”. Da notare che alla fine del libro, il narratore (presenza sommessa ma costante che attraversa tutto il romanzo) fa ammettere al dottor Rieux di essere il narratore medesimo di questa grande storia.
E pare che stia all’uomo, infine, decretare la fine della peste, cosa che può avvenire solo quando finalmente non ne può più. Quando egli, dopo aver sperimentato, toccando il fondo, la prigionia e l’isolamento, torna a domandare il volto della persona amata, quello è il momento in cui si sancisce la definitiva sconfitta del male e si gioisce per il ritorno dei sorci, “bisogna vederli, corrono che è un piacere” (la peste s’era annunciata con una grande moria di sorci).
Tarrou muore inaspettatamente durante la ritirata delle peste e nei suoi taccuini si trova quest’annotazione: “forse non si può giungere che ad approssimazioni della santità; in tal caso, bisognerebbe accontentarsi di un satanismo modesto e caritatevole”.
“La definitiva sconfitta, quella che termina tutte le guerre e della stessa pace fa una pena senza guarigione.”
Comincia qui, Camus, a prepararsi il terreno per La caduta, con questo suo gusto per i paradossi, i colpi di coda, le iperboli.
“Un calore di vita e un’immagine di morte, era questa la conoscenza.”
(continua)
20 Ott 2011 Nicola


