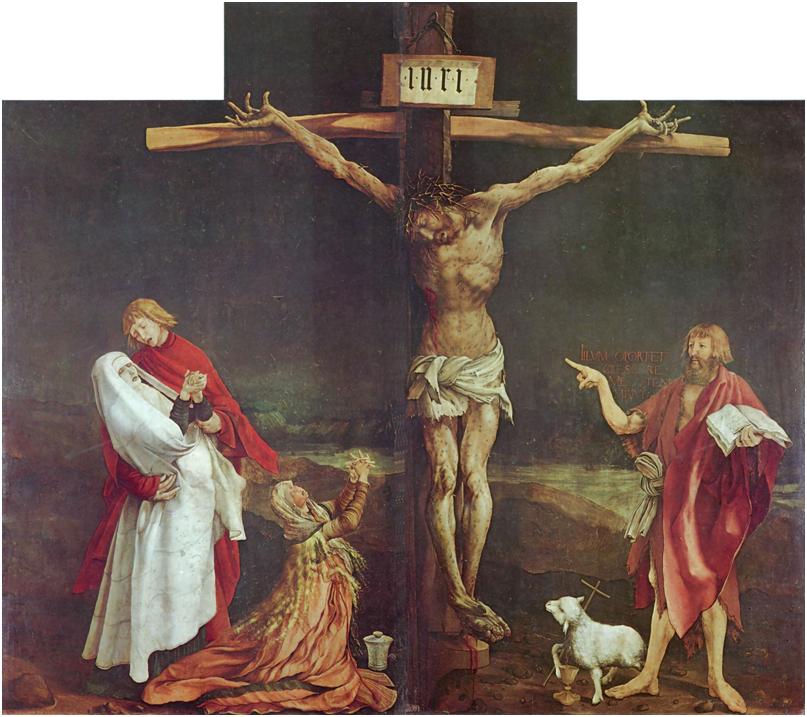Recensione di Giuseppe Giglio, apparsa sul Riformista del 18 aprile 2009
Recensione di Giuseppe Giglio, apparsa sul Riformista del 18 aprile 2009
Gilbert Keith Chesterton diceva che bisognava fare il giro del mondo per ritrovare la propria casa. E in quest’affermazione c’è tutto il senso dell’avventura chestertoniana, l’avventura del man alive, dell’uomo vivo, protagonista di tante storie del narratore inglese. Ma a volte basta fare il giro della propria casa per avventurarsi tra i sentieri della vita. E aprire una finestra sul mondo, capire di più di sé stessi e degli altri, scoprire insomma una porzione di esistenza. Che è poi la ragion d’essere di un romanzo. È quel che accade ne I frutti dimenticati, l’ultimo libro di Cristiano Cavina (Marcos y Marcos, € 14,50). Un romanzo breve – o un racconto lungo – ambientato ai nostri giorni, in cui l’incontro di Cristiano (il trentenne protagonista, pizzaiolo e scrittore al tempo stesso, come Cavina; o meglio: narratore innamorato delle storie) con uno sconosciuto concide con la prima tappa di un inaspettato viaggio: tra un presente difficile e i sogni della memoria (sogni che volano come mongolfiere), tra le pareti della casa e le viuzze del piccolo borgo romagnolo in cui Cristiano – che è anche l’io narrante – è cresciuto. Ove « era tutto un coltivare frutti dimenticati», una vera e propria festa collettiva, ogni anno celebrata: giuggiole, pere volpine, sorbi, lazzeruoli, cornioli; tutti tirati su con amore.
Un viaggio affidato a una scrittura scarna e asciutta, in cui strettamente e sottilmente si intrecciano autobiografismo e invenzione: a disegnare per linee essenziali luoghi e personaggi reali e simbolici al tempo stesso, a dar voce a una libera e felice fantasia che sdipana e avvolge grappoli di vita vissuta o in divenire; tra amicizie e inquietudini, gioie ed errori, passione e avventure, tra le bancarelle dei frutti dimenticati e frutti della vita non raccolti, o mancati. Con la leggerezza, il candore e l’innocenza che della favola sono propri.
E a proposito di favola, di favoloso: questa storia si potrebbe leggere come un’immaginaria cartolina dalla Romagna, di calviniana memoria; dove il fiabesco e il realistico, perfettamente complementari, cesellano un personaggio-uomo che anche a noi somiglia: inquieto e come alla ricerca di un’antica armonia perduta, o non trovata. Un personaggio che dolorosamente ritrova un padre mai avuto (un uomo «molto stanco che con abiti troppo grandi si avvicina alla fine», quasi al capolinea) al quale decide di raccontare la propria vita disordinata, che sembra sfuggirgli di mano, proprio mentre la sua compagna – che non è più sicuro di amare – sta per dargli (a lui, Cristiano) un figlio: un bimbo con occhietti da canaglia, da «unno invasore», e con i «mignoli perfettamente uncinati». Proprio le stesse caratteristiche di Cristiano: che da bambino, come un intrepido palombaro (sprofondato in una vecchia tuta da lavoro del nonno, con sulla faccia una maschera da saldatore), guizzava con straordinaria agilità nella camera della nonna a caccia di mirabolanti tesori, come fosse in fondo all’oceano, sicuro della protezione dei papà che si era immaginato: D’Artagnan, Sandokan, Jean Valjean, il conte di Montecristo, persino Dio.
I frutti della vita, dunque; quelli cioè che alla vita stessa appartengono, che le conferiscono dignità e senso. Dapprima assaggiati quasi inconsapevolmente, poi insinuati nell’animo, quindi riscoperti da adulto; e vissuti come favola di sé: l’assenza, l’inquietudine, la malattia, il dolore, la morte, la gioia, la fantasia, le cose semplici, i bambini, l’amore. Soprattutto l’amore, la scoperta e riscoperta dell’amore. E il lettore si sente come convitato ad un gioco di intelligenza attiva, pagina dopo pagina. Guizza - anche lui palombaro - nelle profondità cui si spinge il protagonista, a seguirne la difficile rotta. Fino all’epilogo della storia. Quando si torna in superficie, dopo aver recuperato qualche tesoro. Quando la vita finisce e ricomincia. Quando si viene a capo di un agile filo di fantasia che corre lungo le nostre iinquietudini, balugina tra le intermittenze del cuore, si impenna in grappoli di gioia.